Gioconda si chiamava così in onore della famosa opera del Ponchielli, tanto amata da suo padre. Sua madre era una donna molto bella ma forse anche un po’ agguerrita: ebbe infatti tre mariti. Rimasta vedova dei primi due, osò ripudiare il terzo, che aveva preferito volar dietro ai commerci e alla bella vita, e diventò un’abile amministratrice. Gioconda era la figlia tanto attesa, nata dall’ ultimo matrimonio, ma ben presto divenne la testimone dell’ennesima solitudine affettiva; ne pagò quindi le conseguenze con un’infanzia trascorsa sì nell’ agio, ma anche in solitudine e in un ruolo troppo stretto, dettato dalla società dell’epoca. Era figlia del suo tempo anche nella sottomissione alla volontà materna e nella precoce saggezza, frutto della rigida educazione che le fu impartita. L’intima sofferenza dell’anima spesso rende perspicaci: percepì sempre la colpa di esser figlia di un uomo, a lei descritto come ingrato, che le lasciò il nome e un vago ricordo.Il suo più grande atto di ribellione quindi consistette nel parlarne di rado.
La sua giornata scorreva nell’ alternanza di un rosario, lettura di libri, che uno zio le prestava di nascosto, e sporadiche visite a parenti. Ogni tanto si interrompeva per soffermare lo sguardo davanti a sé, verso le colline cosparse di aranceti che si intravedevano dalla finestra, in cerca di nuovi orizzonti. Forse ripeteva mentalmente qualche verso o inseguiva qualche pensiero ed emozione dentro di sé. Probabilmente gli stessi che non sfuggivano a quella bambina, nata nel suo stesso giorno ma circa sessant’anni più tardi, che riposava sul suo lettone e la osservava furtivamente, con discrezione. La piccola spostava poi lo sguardo verso i dolci profili del tondo della Sacra Famiglia, non a caso il quadro preferito di Gioconda.
In età avanzata la signora non era bella, come dicevano fosse stata in gioventù, ma conservò un sorriso dolcemente contagioso e una pronta ironia che la rendevano aggraziata ed interessante. Le stesse qualità che anni prima catturarono il cuore di un giovane, tanto ambito dalle ragazze del luogo. Lui aveva occhi azzurri, un sorriso sincero, un portamento sicuro e un’aria distinta che non passavano inosservati. La notò e iniziò a scriverle dopo aver chiesto il permesso a sua madre. Tra i due iniziò una fitta corrispondenza con missive che riassumevano gli impegni della giornata. Ogni lettera, sigillata da una promessa d’ amore e da una dichiarazione di fede nella Provvidenza, era accompagnata da una foglia di edera in quelle di lui e da una rosellina o un fiore di campo in quelle di lei. Lo scambio epistolare si svolgeva grazie al fidato mulattiere o qualche fornitore che avvicinava la tata di Gioconda. Le giornate trascorrevano nella trepida attesa di quelle lettere, finchè furono annunciate le nozze. Un grande e atteso evento, cui parteciparono anche gli zii lontani, compreso quello che viveva a Londra.
Così Gioconda finalmente potè uscire da sola e iniziò a sperimentare l’amore e la vita, anche quando lui partì per la seconda volta per il fronte. Altre parole scritte custodivano un legame profondo che nessuna vicenda personale e storica poteva scalfire. Tra le due guerre ebbero sette figli ma sopravvissero solo le ultime quattro figlie. Durante la seconda guerra lui fu richiamato alle armi, ma per poco tempo perché, ammalatosi, fu mandato a casa dove ben presto decise di occuparsi anche dei tanti nipoti, rimasti orfani di entrambi i genitori. Gioconda, all’insaputa del marito che era al fronte, vendette il corredo ricevuto in dote e i gioielli di famiglia che non indossava mai. Inoltre dovette cedere il suo appartamento al comando angloamericano, mentre aitanti giovanotti dormivano giù nel deposito che, prima dello smantellamento, era riservato ai cani da caccia e agli attrezzi agricoli. Insieme alla cognata vigilava quando i soldati sbirciavano le ragazze più grandi, ostentando sorrisi maliziosi e smaglianti senza osare più di tanto. Le sue figlie erano ancora bambine e la più temeraria un giorno osò dire “ no meat (to) dogs, meat to me” perché la fame si faceva sentire, più del freddo e della mancanza di abiti e scarpe. La spontanea “sfrontatezza” le procurò un piatto di polpette. Gli ufficiali stimavano quelle donne energiche che in tempi difficili fronteggiarono in silenzio i lutti, le difficoltà e gli stenti della guerra, industriandosi come potevano tra figli piccoli da accudire, faccende domestiche e parenti sfollati dalla città colpita dai bombardamenti.
Nell’atrio del portone montagne di divise e cappotti smessi giacevano a testimoniare giovani vite spezzate. Un giorno anche quei ragazzi partirono, lasciando l’eco di parole straniere e di risa sonanti. A Montecassino la storia interruppe il corso della loro vita. La guerra finì. L’azienda di famiglia, già caduta in bassa fortuna durante il fascismo, naufragò insieme ai velieri dediti al commercio marittimo oltreoceano.
Gioconda aveva il suo da fare quotidiano e acquisì senso pratico e determinazione, più per necessità che per scelta. Con il marito si impose perché tutti i nipoti e le figlie studiassero, e possibilmente in scuole pubbliche. Egli non si oppose per gli studi classici, teologici, tecnici e magistrali ma ebbe qualche resistenza per il liceo artistico in città dove poi iscrisse una delle figlie. Del resto anche uno zio era pittore e i suoi quadri di scene e cani da caccia ne erano testimonianza. Apparentemente distaccato, con quella figlia era in sintonia anche se la rimproverava perché troppo esuberante ed estroversa, perché andava sempre in bicicletta e giocava a tamburello meglio dei ragazzi del paese, che facevano a gara per sfidarla nel gioco e conquistarla in amore. Quella figlia straordinaria, formatasi in città, in seguito con ironia e sobrietà dimostrò che la vera libertà non necessita né di conferme affettive né dei consensi di una società all’epoca limitante, se non quelli della propria coscienza; preferì non sposarsi e trasmettere ad alunni e nipoti l’amore per le arti, il bello, la natura, il nuoto, la vita nella sue varie sfaccettature. E Gioconda, se si rammaricava per le sue mancate nozze, in fondo si compiaceva dell’anticonformismo di quella figlia, con la quale visse in simbiosi fino alla fine.
Sin da ragazza amava la musica e il canto, che le permettevano di interpretare emozioni sul fluire delle note. Anche in età avanzata si concedeva il lusso di andare ai concerti serali di Ravello con la figlia e la bambina, che trascorreva le vacanze estive a casa sua. Per l’occasione indossava uno scialle e il vestito buono, poco difforme da quello solito, sempre a piccoli pois o fiorellini azzurri su fondo nero o blu. La bambina contemplava davanti a sé le sfumature violacee che univano mare e cielo nel crepuscolo, poi congiungeva le stelle in disegni immaginari ispirati dalla musica . “ La musica si ascolta a occhi chiusi. Vibra dentro e trascina” e così si rannicchiava sotto il suo scialle. Rientravano a notte fonda con la 500 dalla capote abbassata. Talvolta cantavano, finchè la bimba si addormentava sul sedile posteriore, cullata dalle curve tortuose della costiera amalfitana.
Gioconda credeva. Chissà se per convinzione o per bigottismo. Aveva comunque approfondito la dottrina .Ogni settimana contattava un prete per le messe da celebrare nella cappella, che divenne un punto di riferimento per tutto il vicinato, amici e parenti. La fede non le tolse mai il sorriso e la capacità di accettazione, anche quando dovette affrontare la lunga malattia del marito e lutti prematuri. Se la fede fu per lei un sostegno costante, invece la generosità divenne una regola di vita verso chi le chiedeva consiglio o si trovava in difficoltà e non osava chiedere. Divideva quel poco che aveva: un pacco di zucchero, pasta e caffè, a volte un piatto di frittelle di fiori di zucca, ortaggi appena raccolti nell’orto, accompagnati dall’immaginetta di qualche santo e Madonna, che di buon ora la bambina consegnava a persone sconosciute, percependo il significato di quel gesto da cordiali saluti e ringraziamenti o da sguardi tacitamente riconoscenti.
La sua casa era il ritrovo di tanti… delle figlie, dei nipoti, pronipoti e cognate/i partiti per le missioni, per mare e terre lontane in cerca di fortuna nel dopoguerra, per scelta o vocazione. Quella casa era sempre aperta a tutti e la porta non era mai chiusa a chiave. La domenica mattina gli uomini si riunivano per discutere di politica con suo marito, costretto a letto; di pomeriggio i bambini giocavano in cortile fino a sera inoltrata, quando qualche mamma non li chiamava dal balcone. Allora la grande sala da pranzo si animava di donne, che improvvisavano la cena, e di uomini che rientravano dal lavoro. Intanto Gioconda ascoltava dai più piccoli il resoconto della giornata oppure organizzava con due figlie le attività di ricamo per la mostra di beneficenza.
La gente del paese andava periodicamente a farle visita . La bambina disponeva su un vassoio i bicchieri che poi portava camminando pian piano per timore di farli cadere. Offriva sciroppo di amarene, nocino, amaro di mirto o giulebbe di limone che aveva aiutato a preparare, selezionando i frutti migliori, filtrando e travasando più volte con garze sottili. Mentre giocava con uno dei tanti gatti di casa, osservava gli occhi e i gesti degli ospiti. Ascoltava i loro aneddoti, racconti, i frammenti di saga familiare cercando di districarsi nella sua mente infantile tra gli intrecci genealogici, in cui spesso si smarriva, e di ricostruire logicamente la storia dei fatti e degli affetti .
In tarda età Gioconda usciva di rado ma a un rituale estivo non rinunciò mai. Ogni estate doveva fare sette, otto bagni al mare. Quando la 500 gialla, con la capote sempre alzata, arrivava nel borgo marinaro, i vecchi pescatori uscivano dai munazeni e le andavano incontro per salutarla. Le ricordavano i figli, ormai uomini e perlopiù naviganti, e le presentavano le nuore e i nipoti.
La bambina rideva quando assisteva ai preparativi per l’immersione in mare perchè Gioconda non indossava un normale costume da bagno, ma una palandrana di cotone nero, lunga fino al ginocchio, abbottonata sul davanti e con le mezze maniche. Mutandoni neri, una sorta di bermuda, completavano l’abbigliamento da spiaggia. Come riuscisse a galleggiare, era un mistero! Teneva il mento in alto e la testa diritta, cercando di non bagnare i capelli raccolti, e muoveva le mani in fuori per spostare leggermente l’acqua. Si beava nel mare limpido e fresco sotto i costoni rocciosi ed esortava la bambina a tenersi a distanza, forse perché temeva di bere o di affondare trascinata giù dalla pesante palandrana. La piccola la precedeva, nuotava sott’acqua fingendo di cercare conchiglie e stelle marine sul fondale. In realtà era incuriosita da quella specie di elegante manta nera che avanzava lentamente .Un giorno un anziano pescatore volle portarle in barca a remi . La superba costa alta che si stagliava nel cielo terso, le acque cristalline e la nostalgia indussero Gioconda a rivivere un passato ormai remoto nella rievocazione ironica di famiglie e personaggi, che con i loro soprannomi e aneddoti popolano la storia di ogni paese.
L’estate trascorreva placidamente tra persiane socchiuse per mantenere un po’ di fresco nell’antica casa durante la siesta pomeridiana. La bambina giocava tra le ante a specchio dell’armadio: si divertiva a congiungerle quanto più poteva per vedere la propria immagine riflessa per decine di volte, all’infinito. Correva alla finestra non appena sentiva suonare il campanello, sperando di dover calare giù il cestino. Aveva imparato, dopo qualche disastro, a mollare pian piano la corda arrotolata e a tirarla su ancor più lentamente per non farla oscillare e rovesciare la bottiglia di latte fresco che una vicina consegnava ogni sera. Altri passatempi consistevano nella preparazione di infusi di erba e petali di fiori nell’alcool per ottenere miscele colorate o nell’usare il macinino per tritare i chicchi di caffè. Appena poteva, sgattaiolava con il cane in giardino per andare su una bicicletta sgangherata e giocare con i cugini, contendendo poi l’amaca per riposarsi. Il divertimento più spassoso però era nell’orto: trascinava a fatica la pompa lungo il viale e poi innaffiava tutto. Bagnata e sporca di terra, fiera rientrava in casa portando un cesto pieno di pomodori, basilico, prugne ammaccate e trovate in terra, fiori freschi recisi maldestramente (…tanto i santi non avrebbero notato questo particolare). Gioconda non la sgridava ma l’ aiutava a ripulirsi. Se invece era esausta per una giornata trascorsa al mare, alle prodezze domestiche la bambina preferiva il riposo sul lettone e, dietro un giornalino, spiava sottecchi . Lei stava seduta al tavolo tondo intarsiato mentre lavorava all’uncinetto; all’improvviso con tono teatrale improvvisava uno spiritoso dialogo con il Signor Gatto di turno che partecipava miagolando, fuseggiando e spingendo la testa sotto la sua mano per farsi accarezzare. Entrambi alludevano alla bambina e le facevano capire che l’avevano scoperta. Nell’ultimo periodo interrompeva il lavoro, stava immobile e osservava in silenzio davanti a sè. Forse si smarriva in una preghiera, un ricordo o un presentimento…
La Signora Gioconda capiva più di quanto non desse a vedere, non si adirava mai e quando doveva dire qualcosa di importante o serio, affrontava con indiretta ironia l’argomento, ricorrendo a metafore, aneddoti e domande. Con la sua presenza trasmetteva una serena fermezza e con la sua compostezza un apparente distacco dalle umani passioni.
Pareva che vivesse in un mondo suo, dipinto dalla garbata gentilezza, da una taciuta forza d’animo, dalla coerenza e fede ai principi, dalla discreta e pudica ritrosia a esternare impulsivamente le emozioni più forti e i pensieri più profondi.Un mondo fermo ed immutabile nel tempo, in una casa senza orologi. Tempo scandito dai fiori di stagione e tralci di edera raccolti in giardino, dai racconti, dai quadri, dai mobili, dagli affetti.
Un mondo di radici mai strappate che mi appartiene, come il patrimonio interiore di cose semplici e belle che mi ha donato nonna Gioconda.

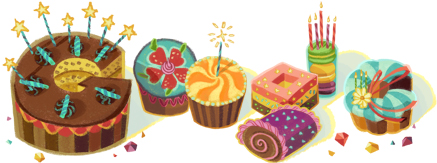
 Follow
Follow

 , bensì dall’acaro delle meraviglie. L’
, bensì dall’acaro delle meraviglie. L’ 

