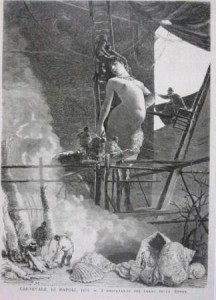E chi l’avrebbe mai detto che la pizza si ricollega alla guerra tra il bene e il male nell’antica mitologia greca? Quando il dio delle tenebre Ade rapì la bella Persefone, figlia di Cerere, la dea afflitta iniziò a cercarla e giunse in incognito ad Eleusi. Qui il re Celeo e sua moglie Metanira piangevano per la triste sorte del loro figlioletto Trittolemo che stava per morire perché privo del latte materno. Cerere donò forza, vigore e immortalità al piccolo per ricambiare dell’ospitalità ricevuta e, quando Metanira le offrì una coppa di dolcissimo vino, chiese una bevanda fatta di farina e acqua aromatizzata con basilico.
Pare che nel corso dei secoli questi ingredienti siano stati usati in dosi diverse e, con l’aggiunta di olio, abbiano poi dato origine alla plax , una sorta di focaccia.
 Nell’antico Egitto si usava festeggiare il compleanno del faraone consumando una schiacciata condita con erbe aromatiche; nell’antica Grecia schiacciate e una sorta di focaccia di farina d’orzo, la cosiddetta maza, erano alimenti molto diffusi, come nell’antica Roma focacce lievitate e non, tra le quali la placenta e l’offa impastata con acqua e farro. Proprio nelle botteghe di via dell’Abbondanza a Pompei furono scoperte scodelle per il cacio e la cuccuma per l’olio e addirittura una statuina del « placentario » conservata nel museo archeologico di Napoli.
Nell’antico Egitto si usava festeggiare il compleanno del faraone consumando una schiacciata condita con erbe aromatiche; nell’antica Grecia schiacciate e una sorta di focaccia di farina d’orzo, la cosiddetta maza, erano alimenti molto diffusi, come nell’antica Roma focacce lievitate e non, tra le quali la placenta e l’offa impastata con acqua e farro. Proprio nelle botteghe di via dell’Abbondanza a Pompei furono scoperte scodelle per il cacio e la cuccuma per l’olio e addirittura una statuina del « placentario » conservata nel museo archeologico di Napoli.
In verità la pizza ha una lunga, complessa e incerta storia. La parola “pizza” risale al latino volgare di Gaeta nel 997 e di Penne nel 1200; nel ‘500 a Napoli si chiamava “ pizza” un pane schiacciato, dalla storpiatura della parola “pitta”. Tra il Cinquecento e il Seicento a Napoli si faceva una pizza soffice “alla mastunicola”, preparata con strutto, formaggio, basilico e pepe, più tardi quella con i “cecenielli”, cioè bianchetti; mentre fu condita con il pomodoro forse a metà Settecento.

Più controverso ancora è l’arrivo dei bufali in Italia:per alcuni essi furono importati dall’Africa dai Romani e si ambientarono facilmente nella piana del Volturno e del Sele, per altri furono portati dai saraceni ma solo i longobardi li sfruttarono al meglio. Il pomodoro sbarcò a Napoli solo dopo la scoperta dell’America e presumibilmente nel 1550, in cucina anni dopo.
Sulle origini della pizza esistono diverse versioni, a volte un po’ fantasiose. In verità la pizza non ha un’unica paternità: si sa che è nata a Napoli dalle esperienze trasmesse di porta in porta, di vicolo in vicolo. Nel ‘700 la pizza veniva cotta in forni a legna per essere quindi venduta nelle strade e nei vicoli della città: un garzone di bottega, che portava in equilibrio sul capo una piccola stufa, consegnava a domicilio le pizze variamente condite, preannunciando il proprio arrivo con versi e richiami tipici. Tra il ‘700 e l’800 la pizza diventò un alimento largamente diffuso e apprezzato e quindi si affermò sempre più l’abitudine di gustarla presso i forni oltre che per strada o in casa. Nacquero quindi le pizzerie ove si cimentarono dinastie di pizzaioli.
Prime notizie documentate sulle pizzerie risalgono alla fine del 1700: nel 1762 esisteva a Napoli, nella salita di santa Teresa degli Scalzi, la pizzeria di “Ntuono Testa” frequentata anche dai re Ferdinando I e Ferdinando II di Borbone.
Nel 1780 sorse nella salita S.Anna di Palazzo la pizzeria “Pietro e Basta Così”, divenuta poi pizzeria Brandi , che ancora oggi è una delle più famose pizzerie della città. Si trovava di fronte al palazzo Reale e da qui il cuoco Raffaele Esposito guardava spesso il tricolore con lo stemma sabaudo che sul balcone del palazzo informava della presenza dei reali. Il pizzaiolo, come l’intera città, si sentiva onorato della nascita del piccolo Vittorio Emanuele III a Napoli ,voluta dal re Vittorio Emanuele II, e così decise di fare un dono alla regina Margherita mettendo a frutto la sua creatività gastronomica. Ispirato dai colori del tricolore pensò di usare il verde basilico, la bianca mozzarella e il rosso pomodoro per condire una pizza patriottica alla quale diede il nome di Margherita in onore della prima regina d’Italia.
Nel giugno del 1889 il pizzaiolo fu invitato alla reggia di Capodimonte perché preparasse le sue famose pizze alla regina che desiderava qualcosa di nuovo. Una splendida occasione per fare conoscere la sua pizza margherita. Don Raffaele con la moglie Maria Giovanna Brandi si recò alla reggia su un carretto trainato da un asinello portando tutto il necessario per la sua nuova specialità. Preparò tre pizze: una bianca, con olio, formaggio e basilico, una con i cecenielle (pesciolini) e infine una con mozzarella, pomodoro e basilico.
Tra lo stupore dei cuochi, inebriati dal profumo dei semplici e comuni ingredienti, la regina gradì molto la pizza tricolore, che in suo onore fu battezzata pizza margherita. Questa ottenne un certificato d’onore e ancor oggi la pizzeria Brandi in via Chiaia espone un documento firmato da Camillo Galli, capo dei servizi di tavola della reale casa dei Savoia, ove si attesta il merito della famosa pizza margherita.
La più semplice e gustosa delle pizze, destinata a entrare nella tradizione culinaria di Napoli, nata per sopperire alla cronica fame del popolo napoletano conquistò ben presto una fama mondiale.
Articoli correlati:



 Follow
Follow